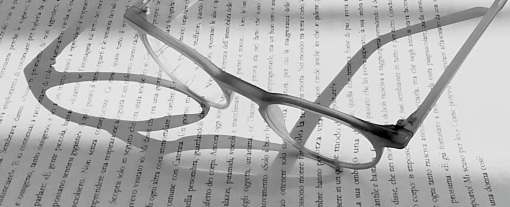«Don Ponzio Capodoglio» di Giorgio Pressburger

Ho letto «Don Ponzio Capodoglio» di Giorgio Pressburger (Marsilio, 2017) e dico subito che è un libro che si presta a più letture e stimola più riflessioni, un po’ come tutti i libri belli, insomma.
Non amo molto riassumere le trame, ma qui vale la pena farlo un pochino, ché c’ha il suo perché. Dunque: prendete un uomo segaligno con una fissazione (sì, tipo Don Chisciotte). Poi dategli come compagna una donna grossa grossa, di 150 chili per intenderci, con un’apertura mentale ben diversa della sua, non si sa se per saggezza o per pigrizia (sì, tipo Sancho Panza, ma più alta e con delle cosce così!). Quindi prendete una gatta che si fa i fatti propri sebbene venga considerata alla stregua di una delle amiche più care che si possano avere, soprattutto per lei (sì, tipo ronzinante ma molto più basso e bianco, forse come il ciuchino di Sancho). A questo punto inventate una buona motivazione per farli partire in un viaggio avventuroso (sì, come per salvare Dulcinea del Toboso, solo che in questo caso la ricerca è della propria identità). Spolverate il tutto con qualche botta e qualche legnata. Metteteci scene al limite del caricaturale e otterrete l’avventurosa storia di una specie di enorme balena con la quale godrete nello spendere qualche ora di buona compagnia letteraria.
Se Don Chisciotte aveva un tono epico, cavalleresco, qui il viaggio dell’eroe mancato pare essere narrato da un cantastorie specializzato in fiabe (almeno in parte). A tratti ho pensato che potesse essere un libro da leggere a voce alta persino ai bambini. Se non fosse per alcuni spezzoni che definirei alcuni come «sfoghi filosofeggianti», altri «sfoghi political-animalisti» ci ho trovato pure un bel po’ di «lezioni per aspiranti scrittori». In merito a quest’ultima sezione (fatta da me, eh, nel libro non esistono queste suddivisioni, sia chiaro) ammetto che forse il fatto di appartenere alla categoria citata potrebbe avermi influenzata. Insomma potrei aver filtrato i testi da un punto di vista tutto mio, tant’è che mi sono chiesta a più riprese quanto possano realmente interessare a un lettore comune alcuni passaggi (compresa la prima lunga parte che dovrebbe essere la spiegazione del «contratto tra lettore e autore»; una premessa che io ho trovato interessante, ma che mi sembra essere più una «masturbazione» mentale di chi scrive, che non di interesse per chi legge; di certo mi sbaglio).
Gli slanci animalisti, invece, vanno ben oltre il solito sentito dire, perché mi pare chiaro che venga semmai creato di continuo un confronto tra uomo-bestia e animali-nonBestie nel tentativo di abbattere anche l’ultima, la più estrema, delle barriere razziali. Lo stesso mi pare possa valere con la mescolanza di diversi Credo, giacché emergono pensieri religiosi di varia natura, mi pare, così che pur essendo predominante l’ebraismo può benissimo capitare di apprendere teorie sulla reincarnazione che si mescolano in aggiunta ad altre immaginazioni che a loro volta generano un miscuglio sostenibile e una convivenza per similitudini apparentemente praticabile di varie filosofie di vita. Che in fondo l’identità di che cosa è composta? Mi è piaciuta molto la lettera che Roberto Negrescu scrive al protagonista quando si trovano in Cina. Qui si legge, tra il resto, di pensieri che cercano di indagare il tema in questione passando dalla spersonalizzazione alla ricostruzione di una nuova identità sempre in trasformazione come soggiacesse a continue metamorfosi dove la forma che si modifica non è il corpo ma la mente, a iniziare dall’apprendimento di nuove lingue che snaturano quella originaria, quella identitaria, quella materna (e più avanti si arriverà persino a leggere di una certa necessità di imparare persino il linguaggio dei gatti, o degli animali tutti, a conferma di quanto detto sopra). Un discorso che si riallaccia con altre analogie proposte sin dall’inizio come la moltitudine di traduzioni a cui può essere sottoposto il nome del protagonista (Ponzio di Cappdoglio o Pons de Chapdouille o Chadpdohl o Chapdouvillye o Chapdouville o Chapdeville o Chapduels o Capduch o Capduehl o Capduell o Capdoil o Chatoville o…) oppure il continuo riferimento alla traduzione degli incartamenti ufficiali su cui si basa il romanzo e di cui il lettore è in possesso. O ancora con «battute» del tipo: «…senza riuscire a comprendere che razza di lingua fosse quella – razza di lingua… -…»
D’altronde che cos’è davvero l’origine? Be’ non lo dico io, e nemmeno Pressburger. È già stato detto parecchio tempo fa: «In principio era il Verbo» (Gv 1,1)
Di conseguenza, il capitolo ventottesimo mi ha intrigata ancora di più visto il discorso che verte sulla «funzione di non verità della lingua, dell’illusione di chi si affida a essa».
Dice Negrescu a pag. 290: «A questo punto (…) non c’è più questione di verità nella letteratura e nella vita, ma di autenticità».
Divertente, sì, ma anche sottilmente «saggia» è invece la lettera che Sieglinde , nome della protagonista un po’ in sovrappeso (pag. 298-299) spedisce alla presidentessa della regione Baviera, alla quale regala qualcosa di molto vicino al «nulla» e ne spiega il motivo. Una meraviglia. E poi c’è prêt-à-porter di anonimo. Una sorta di intermezzo, una commedia musicale, una sceneggiatura che ripercorre la storia del mondo, o meglio dei disastri identitari che hanno animato sin dalle origini il mondo. Una passerella di battaglie e guerre e sciagure rappresentate da una sfilata di moda, quale simbolo di tutto ciò che c’è di effimero, come lo sarebbe il pronome «io»: un abito per distinguersi. Eppure alla fine, come recita il testo, o quanto meno come lo lascia intendere, ci presenteremo al creatore tutti nudi. La frase più significativa, per me? È a pag. 241: «Ma puoi conoscere il mondo senza infettartene?»
Quella più utile a me in questo momento? È a pagina 297: «Leggete (…) e ne trarrete beneficio per il vostro buonumore e per il vostro sapere».
E io leggo. E ho appunto letto anche questo libro, ma in questo caso più che essermi arricchita di sapere mi sono arricchita di domande alle quali però, in tutta onestà, non ho ancora dato una risposta definitiva. Perché se da una parte ammetto il buonsenso della morale veicolata qui, dall’altra sono terrorizzata dalla perdita di identità culturali differenti, compresa la ricchezza di varietà linguistiche. Ciò che di fatto sta avvenendo, e me ne sono già accorta più di una volta quando sono tornata in certi luoghi una ventina di anni dopo esserci stata la prima volta…
Tornare all’origine, a una sola unità, a una sola lingua, un’unica identità sarebbe davvero giusto? In verità, una risposta, il libro la dà e, per quanto possa apparire di una disarmante semplicità, è in fondo la visione che mi pare essere la più praticabile ma anche la più saggia. Ma non farò qui nessun tipo di spoiler, oltre quanto già fatto.