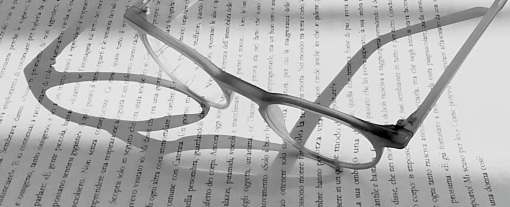«La parte di Malvasia» di Gilda Policastro

«La violenza maggiore sulle donne e sulle creature, nel libro, è la morte, ma prima ancora la malattia, o anche solo l’invecchiamento.»
Ho letto La parte di Malvasia di Gilda Policastro (La nave di Teseo Editore, 2021) e sono lusingata per l’intervista che l’autrice mi ha concesso; ne ho scritto su Azione. La versione integrale del testo – per chi desidera leggerlo ma non ha accesso al cartaceo – si trova scrollando verso il basso oppure online (non richiede iscrizioni perché è un settimanale d’approfondimento gratuito).
«La letteratura è una bugia»
Nel nuovo romanzo di Gilda Policastro, La parte di Malvasia, lo sguardo su vita-e-morte si attorciglia in una forma letteraria sfaccettata
/ 18.07.2022
di Manuela Mazzi
«Era questo, lo scopo del dolore: la sua cura». Un dolore generativo, più che generato dalla violenza del vivere, la malattia, la perdita, i conflitti di genere e interiori, le parti estreme dei desideri, la carnalità e il corpo, la ricerca del male (dal quale, la radice di Malvasia, malvagia); un dolore che arriva a generare la morte, che a sua volta genera dolore, facendosi entrambi oggetto d’indagine, come fossero il morto di cui occuparsi, per il quale binomio forse si vorrebbe trovare una ragione. Tanto è ciò a cui si va incontro prendendo in mano l’ultimo romanzo della scrittrice, oltre che poetessa e critica letteraria romana Gilda Policastro, La parte di Malvasia.
L’avvio del romanzo è volutamente travestito da giallo tradizionale, con la messa in scena del classico «misterioso omicidio della straniera», quasi a voler fare accomodare il lettore, per trasformarsi poche pagine dopo in una scomposizione della materia narrativa che si frammenta sempre più, pagina dopo pagina, trasformando le immagini in taglienti schegge di vetro, nelle quali il male, vero protagonista di quest’opera, tende a riflettersi ma anche a distorcersi per offrire a noi una percezione delle sue sfaccettature più recondite, comprese quelle di un certo disagio psicologico. Il tutto reso da una forma disarticolata, ovvero ricomposta con un montaggio narrativo che disorienta più che inquietare.
Il cosiddetto plot, pur non essendo romanzo di trama, parte infatti dalla scomparsa di una donna, Malvasia, peraltro sconosciuta ai più e arrivata nel quartiere da poco, non si sa da dove. Ad accertarne la morte – presumibilmente violenta e avvenuta per mano di terzi – sono il commissario Arena e l’aiutante Gippo, che avviano le indagini. Da qui il testo perde ogni topos del genere (de Giovanni nel suo blurb parla di «Un’altra sfumatura del nero»), mantenendo tuttavia la tensione narrativa che gioca sulla curiosità del lettore spinto a girare le pagine per capire dove l’autrice vuole portarlo.
Gilda Policastro, la malattia, il male, la morte, ma anche una certa forma di violenza e di impotenza, sono temi a lei cari, considerate anche le altre sue opere come Cella o Il farmaco. Il «male» si presta meglio alla forma del romanzo letterario?
Non so se si presta «meglio», bisognerebbe anche capire qual è l’alternativa, cos’è il bene, come si racconta, o se può essere narrativamente interessante. Ad ogni modo per me la cosa essenziale non è raccontare il male, ma non eliderlo dalla scena, in nome di un malinteso senso della piacevolezza narrativa, o della soglia di tollerabilità del lettore (che si presume sempre omologato, e sempre ingenuo). Lo scorso anno è uscita una serie violentissima che è diventata fenomeno di massa, Squid game, però poi si è gridato allo scandalo per Le ripetizioni di Giulio Mozzi. Non capisco questo recinto stretto di cui si circonda la letteratura: esistono ancora temi interdetti? Pasolini lo processavano per oscenità negli anni Sessanta e Settanta, penso che oggi, al netto della censura di Facebook, che riguarda soprattutto la politica, dovremmo sentirci un po’ più aperti.
In Malvasia le voci narranti si attorcigliano, confondono, poche volte chiariscono con lucide sentenze, altre volte si fanno metaletterarie, e pure capita che si rivolgano al lettore: sono più ammiccamenti o inneschi del dispositivo drammatico?
Niente di tutto questo: il romanzo nasce da un’immaginazione, da una fantasia su una donna morta. Dunque il problema era: come si fa parlare una donna morta? La si fa raccontare dagli altri, ma ci si sente poi responsabili di appropriazione anzi di esproprio di identità. E quindi ogni tanto Malvasia torna a riprendersi quello che è suo, una voce «deportata», per dirla con un poeta a me caro. Malvasia è l’impossibilità di raccontare la morte che solo ci sia dato di vivere, che è quella degli altri. Se gli altri sono persone care, l’appropriazione o l’esproprio è ancora più indebito (e doloroso). Quella fluttuazione risponde a questo tipo di esigenza, ma è più letteraria che programmatica, o forse è più emotiva che letteraria.
Il testo mette talvolta a nudo uno sguardo «maschilista»: quanto contiene Malvasia della dualità maschile/femminile e quanto ha che fare con gli attuali temi di genere?
Quando penso al genere, mi viene in mente sempre l’ambivalenza di Leopardi, in cui il «gener frale» è il femminile, ma poi alla fine la natura umana in quanto tale. Non credo che ci sia uno sguardo maschilista nel libro, ma in generale lo sguardo sui corpi delle donne e sulle qualità prettamente estetiche è uno sguardo che nell’immaginario (soprattutto femminile, a ben pensarci) si consegna o si attribuisce al maschio. Ci si apparecchia per essere guardate. La parte di Malvasia poi è ambientato in un mondo piccolo, in un paese che da un lato è come quello dai confini di gesso di Dogville, ma somiglia anche al paesello di quindicimila anime in cui sono cresciuta e tante donne che conosco, come me, in posti come il paese o il quartiere hanno introiettato lo sguardo del maschio, ma in generale dell’altro. Che poi in un’ottica non maschilista è anche la prima misura della propria identità, fuori dallo specchio.
E in merito alla violenza sulle donne?
Il libro non parla di violenza sulle donne, se non per accidente, con un articolo di giornale, quindi qualcosa di episodico, sebbene drammatico. La violenza maggiore sulle donne e sulle creature, nel libro, è la morte, ma prima ancora la malattia, o anche solo l’invecchiamento. Come dico in un passaggio del libro, quando si è vecchi c’è questa inversione per cui la conquista dell’autonomia della vita adulta regredisce a dipendenza degli altri e tutte le abilità acquisite nel tempo si rovesciano in incapacità e rinunce. Ma qui lo spiego, nel libro lo dico (o lo mostro).
La natura letteraria del romanzo è evidente da stili e forma: quanto sono dati dal godimento che si può trarre da un esercizio di bravura e quanto è funzionale alla narrazione? (Penso ad esempio ai capitoli dialogici, uno reso tale anche graficamente; e alla paratassi di alcuni paragrafi).
Faccio fatica a pensare agli esercizi di bravura come a un problema. Il talento non è da nascondere in nessuna disciplina, sport, arte, solo in letteratura se sei bravo a scrivere te ne devi quasi vergognare e «dirlo peggio», così non spaventi nessuno. Ma perché? Io non mi sono mai spaventata e quando mi è capitato (leggendo Mann, ad esempio), è stato un bell’effetto. Ho cominciato a leggere di più per capire di più, non a leggere cose scritte peggio per capirle meglio.
In che modo dialoga, se dialogo c’è, Malvasia con La cognizione del dolore di Gadda? O altre opere, come I fratelli Karamazov di Dostoevskij?
Con I Karamazov in modo esplicito, perché uno dei temi del libro è l’esplorazione del dolore ma anche della violenza ingiustificata e familiare, come quella dei genitori che torturano senza ragione la loro figlioletta in Dostoevskij. Ma il passo mi serve non in modo didascalico per rivendicare l’innocenza delle creature: al contrario, per indagare la presenza di un mondo pulsionale oscuro che può risultare incomprensibile, ma che pure esiste (quello che all’inizio della conversazione chiamavamo «il male»). La Cognizione è uno dei miei libri formativi: una mia compagna di corso ci fece la tesi, e mi appassionai alle sue ricerche. Nel libro ci sono due citazioni dirette, che non svelo perché sono molto riconoscibili. Quello che mi interessa è come Gadda arrivi alla verità (dell’esistenza, non della trama) attraverso un percorso graduale: con Malvasia ci ho provato, ma nell’esperienza che volevo mettere in forma era più forte la tensione prodotta dallo choc. Io racconto una diagnosi, Gadda un progettato matricidio. Ma forse nella mia «diagnosi» c’era anche questo. Letterariamente, dico.
«La verità è sopravvalutata, io voglio solo bugie. La letteratura è una bugia, la più grande bugia che l’uomo ha inventato», si legge nel romanzo: come può la letteratura svelare verità sul mondo, se di fatto è «sempre» una bugia?
Ah, questo bisognerebbe chiederlo a Dante, che si finge impunemente tra mostri, dannati e diavoli o tra santi e Vergini e nessuno dei suoi lettori, specie ai suoi tempi, gli negava la sospensione dell’incredulità. Quello che voglio dire è che la letteratura è sempre un’operazione a tavolino, il che per altre arti è un’ovvietà. Il selfie che ti sei scattata per i tuoi profili social è un’idea di te, una messa in forma di una cosa che vagamente somiglia a te, ma non sei tu. È una bugia. Malvasia è il mio selfie: ma anche questa è una bugia.
Bibliografia
La parte di Malvasia, Gilda Policastro, La nave di Teseo Editore, 2021, pp. 208.
Al di là della recensione ufficiale.
«Mi chiamo Malvasia, come tutti.»
No, non è una citazione tratta dall’ultimo romanzo di Gilda Policastro («La parte di Malvasia», 2021, La nave di Teseo editore) ma la parafrasi di un noto incipit di Walter Siti che, secondo me, riassume bene questo romanzo spacciato per «giallo» da una fascetta esterna a firma di Maurizio de Giovanni. Già! Un giallo, scritto da una stimata critica letteraria e poetessa appartenente al gotha della Repubblica delle lettere.
Così si chiacchiera un po’ ovunque nella rete. Si vocifera che potrebbe trattarsi di un gioco di comunicazione, di un divertissement dell’editore, per ampliare il target dei lettori, per raggiungere anche gli appassionati del genere «Giallo», marcatura dalla quale, tuttavia, la stessa autrice, Gilda Policastro, ha cercato e cerca di difendere la propria opera (così durante alcune presentazioni), negando sin dalle prime battute qualsiasi reale attinenza con questo genere. E a ragion veduta: «La parte di Malvasia» NON è assolutamente un giallo (e dicendolo sono certa di incontrare il favore dell’autrice). Ma il punto è che nemmeno viene davvero spacciato per tale, bensì per: «Un’altra sfumatura del nero» (secondo la fascetta), che è esattamente quel che avrei detto io per definire quanto ho letto! (E qui sono certa di non incontrare il favore dell’autrice: sorry).
Un’altra sfumatura del noir, si diceva, resa, come aggiunge de Giovanni, con «…una scrittura affilata e acuta come un coltello nel cuore».
LA TRAMA
Dunque? Di che cosa parla questo libro? Per fare il suo gioco dovrei far partire la storia come parte nel romanzo stesso, e troncarla subito dopo, ovvero dovrei dirvi che come capita in molti gialli (l’attacco sì, simula di esserlo, «il misterioso omicidio della straniera», nascondendo dunque la sua natura noir) con la scomparsa di una donna, Malvasia, peraltro sconosciuta ai più, arrivata da poco nel quartiere, non si sa da dove; siamo nel 2018. Ad accertarne la morte – presumibilmente violenta e avvenuta per mano di terzi – saranno il commissario Arena e l’aiutante Gippo, che faranno anche partire una sorta di indagine.
Stop. Da qui in poi (a pagina 43 già si chiarisce il meccanismo) il giallo perde del tutto i topos del genere, per assumere a pieno titolo quelli del noir, pur fornendone una sfumatura ancora più psicologica, e una pasta letteraria, che non inquieta, ma disorienta assai, mantenendo così la tensione narrativa che si gioca tutta sulla curiosità del lettore portato a girare le pagine per orientarsi, per capirci sempre qualcosa di più.
OLTRELATRAMA
La premessa è d’obbligo, per un po’ di anni ho bazzicato la bolla dei cosiddetti «giallisti». Ho scritto «gialli», ma anche thriller e spy story, mentre non ho mai scritto un noir. Non ancora. Ma non è questo il punto. Il punto è che se uno si mette a studiare un po’ questa materia, sa perfettamente che un giallo non è nel modo più assoluto confrontabile o associabile al noir. Certo, per alcuni sono solo variazioni di una stessa specie, ma per chi è appassionato le differenze sono tali da determinare in un certo senso generi diversi, come lo sono il fantasy e la fantascienza, per intenderci. Infatti, il giallo si dà quando è messa in scena un’investigazione vera e propria (molte volte con tanto di commissari e investigatori), che sia per scoprire il colpevole o semplicemente per dimostrarne la colpa. Spesso (non necessariamente sempre) ne consegue un arresto. In somma: il classico. E non esiste che un de Giovanni, o qualsiasi altro del mestiere, possa confondere «La parte di Malvasia» per un giallo!
I Thriller, per dire, devono avere una componente di azione esagerata, sopra le righe, all’americana, con sparatorie, forze armate, corse rocambolesche. Ai noir pertengono invece quei testi che esplorano il male, spesso mettendo in scena i drammi psicologici dei personaggi, non necessariamente solo quelli degli assassini, o esplorano la profondità interiore delle vittime, dove deve annidarsi un male inquietante. Nei noir l’investigazione interessa poco o niente, se non per far sentire la paura del braccato (se è il caso). Nei noir il protagonista è il male. Non l’investigazione, non l’azione, non la teoria legale, non l’aspetto moralistico, no, il male estratto dalle sue pieghe più dolorose e vomitato nelle pagine.
E se «La parte di Malvasia» non è una sfumatura del noir, cioè un modo per esplorare il male, a partire da un reale o presunto crimine, allora non so quale altro libro potrebbe esserlo. Che di male, questo romanzo ne dice assai, basti il riferimento a chi fa la parte del morto, che sarebbe la morte (pag. 120). O l’introduzione del tema già esplorato anche da Giulio Mozzi nel suo «Le ripetizioni»: «…il prete sostiene che il male non sia solo uccidere, rubare, ma anche il contrario del bene, l’apatia morale»; o ancora: «Amina crede che quel prurito di cose sbagliate o proibite sia la vita. Il resto è ripetizione, obblighi, rotture di cazzo».
Alla questione di genere, si è detto per altri versi, è anche legato il tema: il maschile e il femminile, la lotta interna tra questi mondi che coabitati generano fratture non di poco conto. Ma non voglio dilungarmi troppo su questo argomento sul quale si contorce l’intero romanzo.
Un viaggio attraverso il male, visto da più sguardi e narrato da più voci, che si fanno di tanto in tanto persino metaletterari, quando la voce, o una voce, narrante si rispecchia nel lettore rivolgendosi a sé stessa anche con rimprovero: «Con il tempo ci fai il riassunto di cose passate: metti tutto dentro alla buona, come nella ribollita», o come quando dice: «Che poi non deve essere difficile inventare, scrivere un racconto. In prima persona, così quello che agisce sei tu. Certi dicono no, non va bene perché il lettore s’immedesima solo se tu sei un’altra persona, se ti trasfiguri. Quindi sei tu, può pure essere, ma è meglio se ti chiami col nome di un altro».
STILE
Parte con una narrazione, come si diceva, apparentemente tradizionale, in terza persona e lineare, con un narratore che sembra essere onnisciente, esterno con diverse focalizzazioni.
Poi inizia a divagare un po’, adottando di volta in volta espressioni diverse. Dagli sguardi popolari, a volte maschilisti (a lasciar trapelare sin da subito il tema, non tanto sottotraccia, della violenza sulle donne), avvalendosi anche di battute cliché o generalizzazioni in particolare nella prima parte («…perché lei, come tutte le donne, parlava sempre d’altro o di altri»; «Aveva un’andatura rapida come le persone che vivono in città: chissà dove corrono sempre, e perché»;…) alla messa in scena di voci e personalità complementari, con un capitolo addirittura solo dialogico (p. 33-36), o l’altro reso tale anche graficamente (p. 137-139), a ricordare una versione semplificata di alcune pagine contenute nel «suicidio di Angela B» di Umberto Casadei; e poi tanti flussi di pensiero (a pagina 22 si contano 26 righe senza punti fermi, tranne un punto di domanda retorico). Blocchi di testo interi spezzati raramente da paragrafi che tendono a dar respiro al lettore solo per compassione. Mentre i capitoli sono brevissimi, come è uso nei romanzi di genere, per tenerlo, lì, il lettore.
Ci sarà anche tanta poesia. Immagino. Io ho notato giochi tipo quello agito nel capitolo da pagina 43 (che inizia con «Vacca boia, nella testa…») a pagina 45 (che finisce con «vacca boia, era così facile»). Ma in verità, sono di mio troppo ignorante per cogliere i riferimenti ai vari Sanguineti o Menandri.
Certo, si notano i rimandi a Dostoevskij dato che sono espliciti.
Mentre mi pare di aver colto uno stilema trevisano, in quelle parole o espressioni anglofone che entrano a volte a gamba tesa nel testo («…crudeltà, convenzione, what. Gli piaceva»; «…il pesce finisce con l’essere molto pericoloso. My poor child, I’ll never see you again. Anche lì c’erano forni…»; «a’ mamma, il richiamo di tutti i bambini a ogni latitudine, don’t run a Chicago, a’ Giuliaaaa, si fosse trattato di Roma o Napoli»), che mi fanno strano in questo testo, a dirla tutta: Vitaliano Trevisan, si sa, riteneva l’inglese una sua seconda lingua madre, mentre il narratore qui non pare aver motivo di farlo; mi piace pensare comunque che si tratti «solo» di un omaggio. (Non sarà così, ma come si dice sempre, i romanzi si fanno almeno in due: l’autore ci mette il suo e il lettore, l’altra «parte»).
E, non da ultimo, sarà una mia fantasia o deformazione passionale, ho colto un bel paragrafo, che se mi avessero detto che era stato scritto da Hugo Pratt per un dialogo tra Corto Maltese e Rasputin, ci avrei creduto subito: «E quindi dovrei raccontarti la verità, a che punto siamo con le indagini e se lui è implicato. No, non credo gliene importi. La verità è sopravvalutata, io voglio solo bugie. La letteratura è una bugia, la più grande bugia che l’uomo ha inventato».
CITAZIONI
«Quello che non si sa, non rileva»
«Noi siamo fatti per la vita orizzontale, in quella verticale, non ci orientiamo»
«Era questo, lo scopo del dolore: la sua cura»