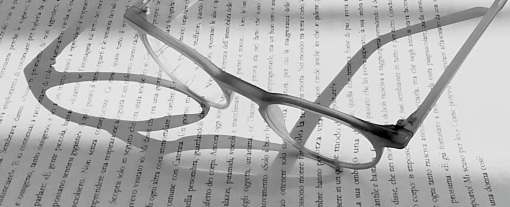«Lo Straniero» di Albert Camus

Adesso dico una delle mie bestialità: può essere che io ci abbia visto la passione di Gesù, nel libro di Albert Camus intitolato «Lo Straniero» (1942)?
Ci sto ragionando. Intanto posso dire che ricorderò questo libro come il libro della «passione», sì, ma anche del caso e delle coincidenze. Non a caso!
Anzitutto il caso vuole che mentre lo sfogliavo mi è stato chiesto di leggere un racconto di Carver, «Lo scompartimento», che molto ha che fare (secondo me). In secondo luogo si è rivelato essere per caso il libro che rileggerò quando mi chinerò (finalmente, ma chissà quando) sul progetto che mi ronza in testa dalla primavera del 2016 (è perfetto il modo, l’ambientazione ma soprattutto la resa della scissione tra l’agire “passivo” del protagonista e l’aspettativa dettata dalle solite convenzioni sociale, se così si può dire) e, infine, perché ci ritrovo per caso una certa mia indolenza verso certi fatti della vita, che nell’ordinarietà del comune vissuto viene poco compresa.
Quindi sarò giocoforza “di parte” per gratitudine. Battuta a parte, non credo di sbagliarmi nel definirlo un bel libro.
LA TRAMA (spoilero)
Un francese in Algeria, Meursault, torna al paese in cui è cresciuto: la madre è morta e stanno per tenersi i funerali, ai quali prenderà serenamente parte. Con una sorta di costante impassibilità (anti-“passione” per definizione), si guarda in giro e si relaziona con persone che sembrerebbe incontrare per caso. Si fidanza per caso, ma potrebbe anche non farlo. Uccide un uomo per caso, perché così gli capita. E per caso si ritroverà condannato alla ghigliottina. E in tutto questo non fa niente per interferire, scegliere, o prendere consapevolezza. Afferma che “quando mi succede qualcosa preferisco esserci”, come se esserci bastasse per vivere (e forse può anche essere così). C’è una sola volta che si lascia prendere da un’emozione, dall’ira, ed è l’unica in cui al lettore viene da pensare: ecco un barlume di passione, e accade quando urla in faccia al cappellano che lui delle storielle di Dio non vuole sapere niente. Ed è in quel momento che a me è tornata in mente una frase letta nelle pagine precedenti e che ora non ritrovo ma diceva una cosa del tipo: “Dunque, secondo te, Lui è morto per niente?”.
OLTRELATRAMA
Bastino le ultime righe del paragrafo dedicato alla trama per giustificare il pensiero sulla passione di Gesù scritto in apertura di questa nota (anche una non passione, parla di passione per forza). A volte mi sembra di capire qualcosa, anche di importante come in questo caso, ma di non avere gli strumenti e la conoscenza sufficienti per argomentare davvero quello che mi è arrivato. E quindi – per ora – lascio lì la domanda. Senza dare risposte. (E, sì, ho ragionato sul significato della parola passione anche se la uso nello stesso modo per “cose” diverse, di proposito).
Aggiungo solo che, forse, anche Cristo, nella mia visione della Grande narrazione (che non conosco) è stato trattato come uno straniero, anche se di altra carne. Qui, leggendo le prime pagine, prima di tutto mi sono però trovata a pensare qualcosa di più semplice: chi non è mai stato straniero persino in casa propria?
La voce è stata una scelta di certo azzeccata perché utilizza una scrittura da diario, di solito molto intimistica, mentre qui fa da contenitore di puri semplici fatti. Fatti buttati là, come a dire il vero scrivo anch’io nel diario: molto più spesso di quello che penso, non scrivo quello che provo od ho provato, ma quello che è accaduto, come se sapessi bene che riproverei le stesse sensazioni (ma non capita così) rileggendomi dopo qualche anno.
Fatti buttati là, come la vita del protagonista – quasi scrivesse per tenersi compagnia da solo, che la solitudine sembra essere una costante, scelta, forse, ma in ogni caso reale. Dice di avere molte certezze su di sé, il protagonista, e vive la morte come estraneità dalla vita. Sembra prendere tutto in modo razionale, ma senza ragionarci. È più probabilmente un uomo che rifiuta di avere un proprio inconscio. Un uomo che vive in superficie. Più che un uomo risolto e davvero consapevole.
Ecco, la percezione che ho avuta con grande forza è stata la scomparsa dalla realtà. Ci sono più modi per essere morti. Quella del protagonista è quasi una morte sociale e famigliare e individuale: perché dovrebbe temere davvero la morte, uno che non è davvero vivo? Pare essere un fantasma che nessuno vede. Ma allo stesso tempo la distanza che la narrazione pone tra lo sguardo del protagonista (che noi lettori seguiamo) e la defunta madre, ma anche dall’amore per la propria donna su cui non sa interrogarsi, e dall’omicidio che commette, è così enorme che la morte vera diventa metafora della realtà, di una realtà senza passione, cioè senza scopo di vita. E questo grazie alla gestione del rapporto tra personalizzazione (il punto di vista dell’Io narrante) e formalità (il tipo di relazioni che si susseguono senza pathos o finta commozione di posa).
E potrebbe andare tutto bene. Cioè: uno può anche scegliere di vivere in superficie (se di scelta si tratta; ma uno straniero non sceglie mai). Perché no? Perché a un certo punto subentrano le convenzioni sociali che colpevolizzano chi non reagisce secondo le aspettative. Se ti muore una madre, devi soffrire. Al di là del giudizio del lettore, emerge dal testo. Ed è un sassolino con enormi potenziali conseguenze: questo meccanismo fa esplodere un miliardo di pensieri e paragoni e riapre situazioni e mostra facce nascoste e mi riporta al progetto del 2016.
Ecco, è questo lo straniamento dello “straniero” che si ritrova a vivere quasi più in una bolla astratta dalla realtà, come a dire che il suo, forse, non è un vero disinteresse, ma incapacità di vivere in modo più integrato; se vivi una dimensione distaccata da tutto, la gente può morire e tu puoi uccidere che sembra essere sempre qualcosa che non ti riguarda.
In questo senso mi ha ricordato quel vago esistere del protagonista del racconto di Carver, ne “Lo Scompartimento” – letto di recente con Silvia, durante uno degli incontri di ragionamenti sui testi che ci siamo prefissate. L’atmosfera è quella e può essere riassunta in un’idea di controllo più generica del tipo: «La vita andrebbe vissuta, non subita». Mentre i protagonisti qui non fanno altro che lasciarsi vivere, per motivi diversi e in modi diversi, ma in entrambi i casi senza prendere parte, senza davvero “esserci”.
In seconda battuta, cioè per quel che riguarda la parte finale del libro, mi ha dato anche modo di ragionare sugli «opposti» (in quanto punto di vista, ragionamenti, ideali, ecc) di questo testo rispetto a quello de «L’ultimo giorno di un condannato a morte» di Victor Hugo (1829): sembra un complemento, anzi, l’antitesi dello stesso. Molto interessante.
IN CONCLUSIONE
È un libro bello, sì, perché oltre a quanto già scritto, avrei così tante cose ancora da dirne, e ciononostante ho la sensazione che dovrei scoprirne ancora tante altre.