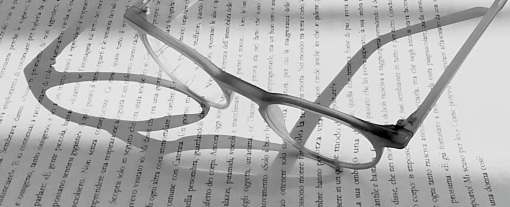«La straniera» di Claudia Durastanti

«La straniera». Così si intitola il romanzo di Claudia Durastanti (Nave di Teseo). E no, non c’entra niente con «Lo straniero» di Camus, per cui non entro nemmeno nel merito. Mi è piaciuto. Lo dico subito. Mi ha sorpresa in modo positivo. È un libro che si fa leggere alla svelta (o forse è l’effetto dopo «Karenina»). Ho trovato originale il tema, lineare la storia, azzeccata la struttura, abbastanza onesta la voce, curiose alcune metafore, e nonostante qualche accenno al “femminismo”, l’ho trovato un libro che ha poco del femminile (e per me è un complimento di gusto, non amando il genere troppo spruzzato di rosa). E infatti ha un punto di vista sulle cose, sul mondo, sulle vicende, sul relazionarsi, sul sentirsi straniera, che riconosco.
LA TRAMA
Un uomo e una donna, entrambi sordomuti, ed entrambi menefreghisti di essere sordomuti, si incontrano ognuno secondo i loro ricordi, si uniscono, si usano, si tollerano, si distruggono forse anche un po’. Dalla loro relazione nascono due figli. La protagonista, io narrante, è l’autrice che attraverso le vicende della vita dei suoi genitori, dei loro parenti, di esperienze proprie racconta un mondo pieno di emozioni mai davvero nominate; come se spettasse a lei trovare le parole per tutti. E ci riesce. E ci riesce bene. Riuscendo a evitare anche qualsiasi tipo di retorica vittimistica. D’altronde essendo autobiografia, non le serve attingere ai pregiudizi, ed è questo di certo un vantaggio e un valore importante che è riuscita a dare al suo romanzo.
Sulla questione della straniera, intesa in tutti i modi (persona di altra nazionalità, ma anche persona “diversa”, di altri “mondi”): non ho da dire nulla, se non che in parte ha aumentato la voglia di scrivere un romanzo che ho in mente da un po’. Come dicevo, il suo punto di vista è qualcosa che capisco e sento bene.
OLTRELATRAMA
Il rischio di cadere nel patetico, con una storia così tra le mani, era di fatto elevatissimo. O forse no. Forse, come dicevo sopra, il fatto che la storia è «vera» le ha permesso di stare sul pezzo senza cedere alla tentazione di vittimizzare due portatori di andicap, che vittime non sono mai stati davvero dell’andicap, ma semmai delle loro scelte di vita. Eppure qualche volta ha ceduto alla tentazione di drammatizzare, tant’è che se la storia non fosse stata dichiaratamente autobiografica, sono abbastanza certa che avrei trovato cose fastidiose. Pochissime, eh, pochissime e pure giustificate alla fin fine.
Ma andiamo con ordine, intanto, ho amato il gioco che ho già incontrato in altri romanzi e mi permetto quindi di dire che è quasi «di moda»: anche la Durastanti costruisce la storia con continui ritorni nel passato che le permettono di cambiare il punto di vista della stessa vicenda, o anche semplicemente di aggiungere parti di un’altra versione, un altro pensiero. Così facendo manda avanti la storia, e allo stesso tempo riempie dei vuoti. Il risultato è una trama comunque lineare, scritta con una “falsa” complessità.
Quello che mi ha un pochino irritato, e mi capita sempre in queste occasioni, è il fatto che la Durastanti a tratti spinge un po’ troppo sulla retorica del male usando molto il sangue come sistema di immagine (nei tramonti, nel vestiario, in certi colori della natura, nei pensieri…), ma del sangue ne scorre poco, per cui a me sembra una forzatura. Faccio un esempio su tutti: «Quando il sole tramonta in Basilicata, il cielo si tramuta in un polmone che espettora sangue, la luce fa tossire più che commuovere». Ma spinge anche su altre cose, dove non mi pare di sentirne il bisogno, come quando descrive un ragazzo al quale viene impedito di scattare delle foto come un “traumatizzato”. Ecco, a me queste aggiunte di contorno a una storia che non ha bisogno di questo per far sentire sottotraccia forme di tragedie quotidiane, non servono. Anzi, sono di troppo. Le percepisco come tentativi di manipolare le emozioni del lettore. Sono quel tipo di spinta per far dire “Oh!”, che a me invece fanno un po’ scendere la catena. E mi fa perdere di verità…
Eppure, c’è un eppure. Ed è la prima volta che mi sento alleggerita da questo “peso” proprio grazie alla narratrice. Narratrice che all’interno del libro fa una sorta di “ammissione di colpa” (come la intendo io, eh). Cioè c’è quasi un capitolo intero dove parla di metafore e di sottotitoli. Ne trascrivo degli stralci:
«La separazione riguarda ogni figlio, la mia avviene per inflessioni e figure retoriche inaccessibili. Ogni ironia ci separa, ogni metafora ci allontana. (…) La mia sintassi è spesso contorta, è l’unico tributo che mi resta. (…)».
Mentre l’intera parte dedicata ai sottotitoli della televisione mette in evidenza quanto lei stessa tenga a questo tipo di spinta, giacché vorrebbe che fossero molto più evocativi: «Vorrei che tutti quelli che lavorano nei sottotitoli fossero poeti».
Ecco, la Durastanti è forse l’unica autrice (senza distinzione di genere) che mi permette oggi e mi permetterà in futuro di accettare immagini più cariche di senso, perché ne comprendo la ragione. Oddio, io non sono sordomuta, per cui non mi servirebbero, ma essendo lei cresciuta comunicando con chi ha bisogno di una traduzione della realtà il più evocativa possibile per poter sentire oltre che vedere, la giustifica: in pratica credo che il suo scrivere sia l’unico modo per andare oltre le immagini.