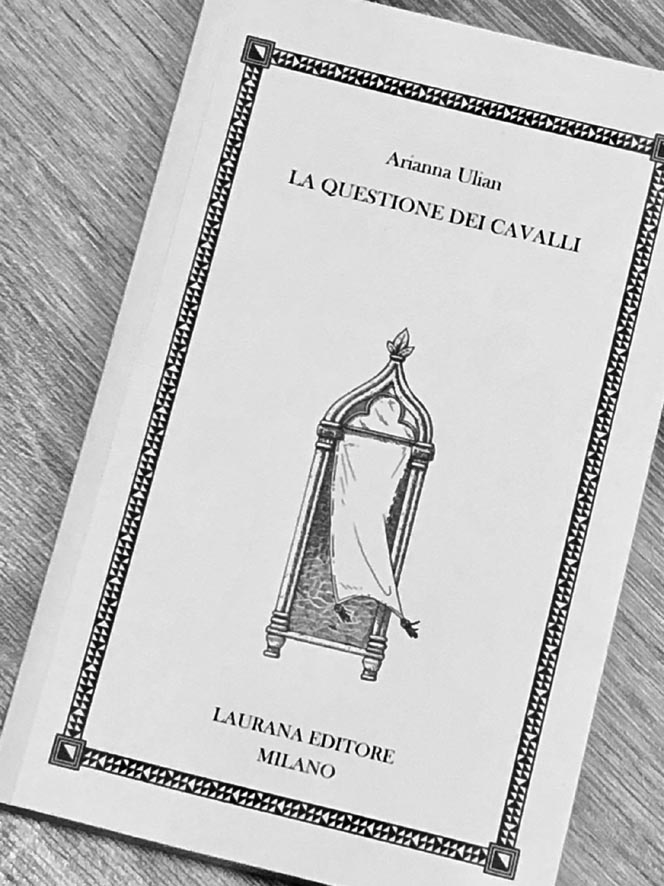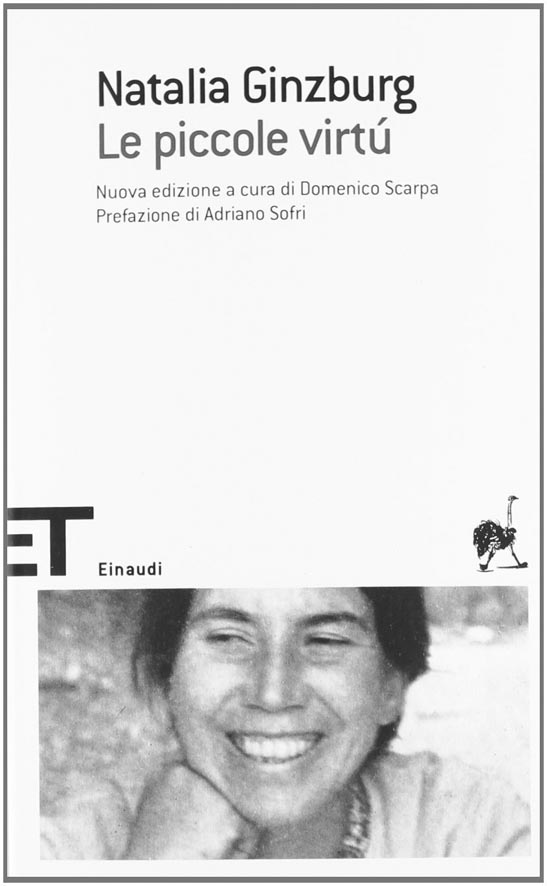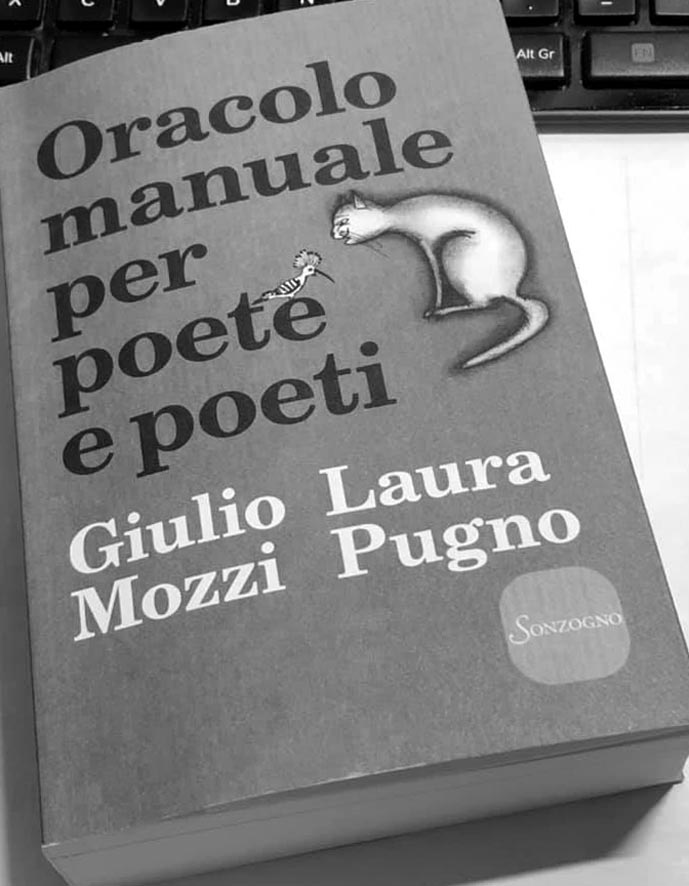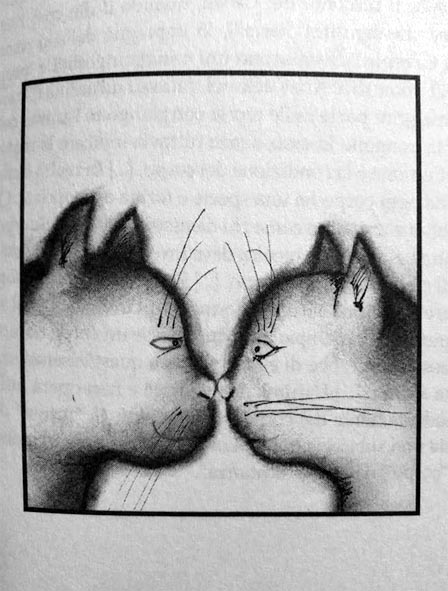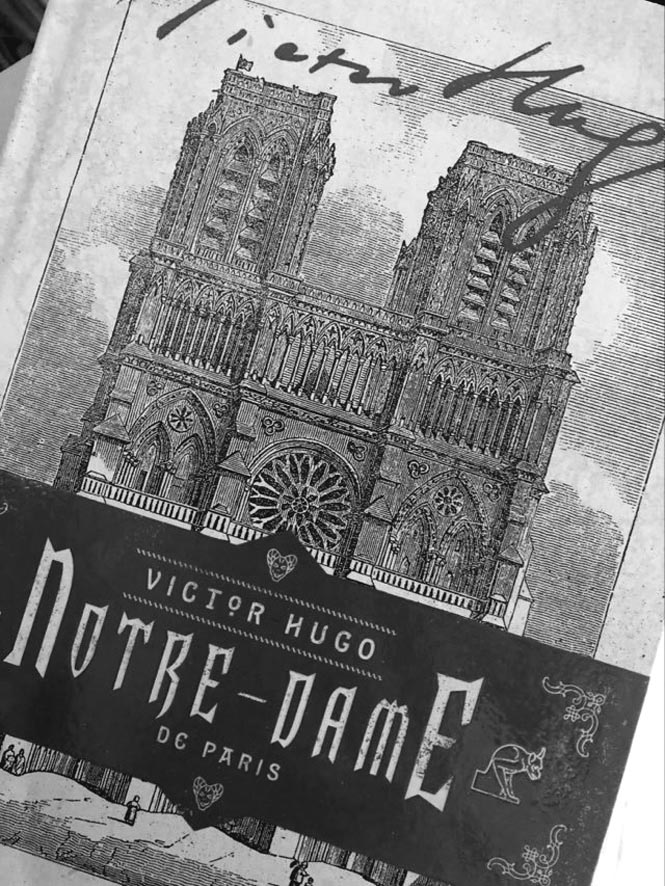«La questione dei cavalli» di Arianna Ulian
Un giorno mi sono svegliata Momo. Per chi non lo sapesse ancora, Girolamo detto Momo, è il piccolo co-protagonista de «La questione dei cavalli» di Arianna Ulian, romanzo uscito da poco come prima opera della collana Fremen, diretta da Giulio Mozzi per l’editore Laurana di Milano. Arianna è un’amica. Sì. Meglio dirlo subito prima di ricevere qualche contestazione. A dirla per bene, spesso agli amici faccio il favore di non scrivere note ai loro libri che leggo. Ma quando mi capita di leggere libri di amici che tanto mi piacciono…
Dicevo, un giorno, dopo averlo letto, mi sono svegliata Momo. Stavo dalla parte di qua a guardare con un binocolo i cavalli morenti. Sette cavalli isolati su un isolotto, come i sette miliardi che siamo sulla terra. Si disfacevano per colpa di figuranti nei panni sbagliati, gente che invece di fare quello che dovevano fare si distraevano, voltavano le spalle all’isola, si ubriacavano tra loro, e intanto i cavalli deperivano, e io guardavo e pensavo che non avevo potere, che anche se avessi gridato, oh! Vecchi sanpietrini sbeccati!, mo svegliatevi però perché quei cavalli stanno morendo e voi scartabellate scartoffie e roba burocratica e il tempo passa, e per tutti gli zoccoli incrostati, quanto siete stupidi, ed è possibile che animali così potenti e perfetti e dignitosi debbano restare proprio per la loro potenza irruente, là a morire per colpa di chi ne ignora quasi l’esistenza? E pensavo a tutto questo, mentre mi sistemavo un cappellino, e mi struggevo.
Un giorno mi sono svegliata Momo e quel giorno ho capito quanto mi era rimasta dentro quella storia, descritta con una lingua così potente.
Continua a leggere “Sette miliardi e un atollo”